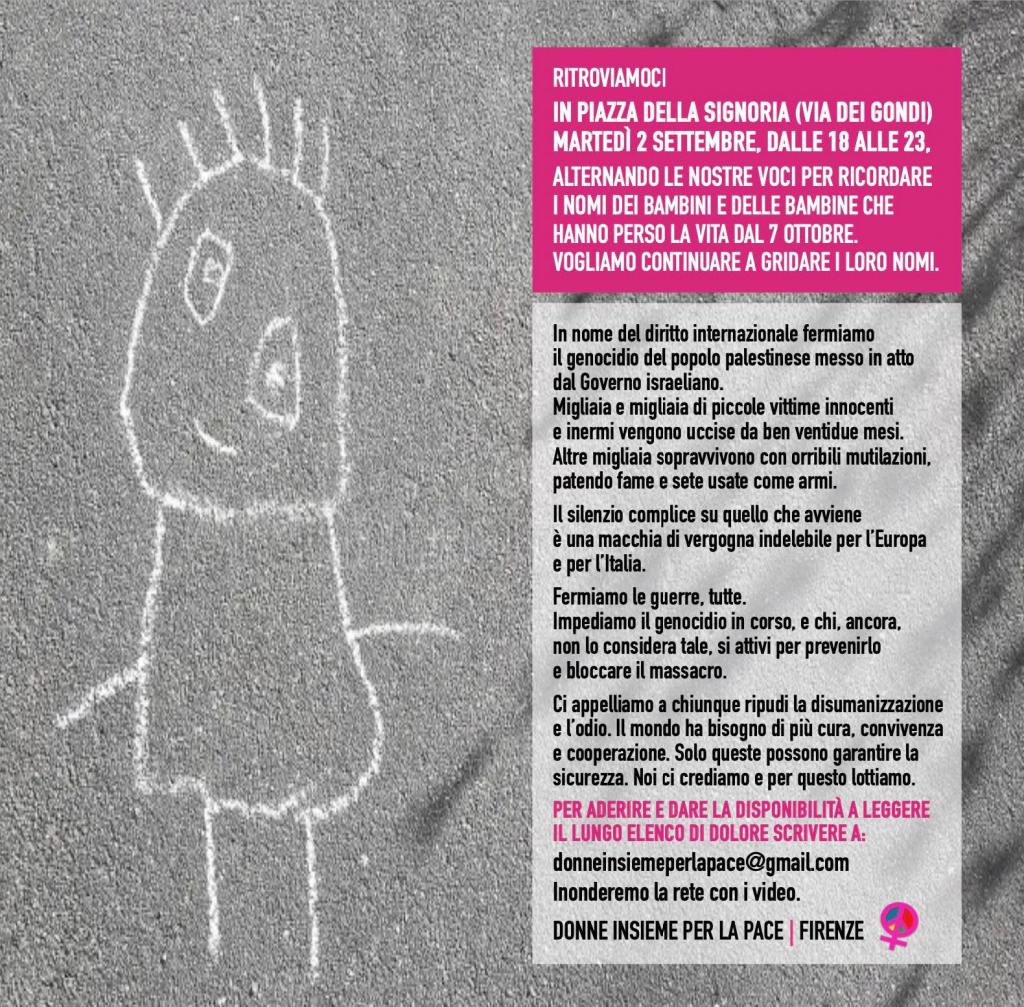Gli orchi non vivono in luoghi impervi o in capanne abbandonate, non vivono neanche in mezzo a noi, anche se somigliano a noi. Gli orchi vivono in ville esclusive, in zone dove noi, al limite, possiamo stare solo al loro servizio, come domestici o come schiavi.
Non mangiano solo fanciulle e bambini: mangiano tutto. Sono come i Langolieri del libro di Stephen King, solo che non divorano solo il passato, divorano anche il presente e, soprattutto, il futuro.
A loro piace apparire, essere i protagonisti di un’estetica invidiabile.
Si riuniscono: ufficialmente in luoghi dove, vestiti formalmente, decidono delle sorti del pianeta; privatamente in regni artificiali dove, più o meno vestiti, si lasciano andare a giochi proibiti, e i giocattoli siamo sempre noi. Ci possono prendere e usare a loro piacimento: ci masticano e poi ci sputano.
Ci sputano anche quando non ci masticano.
Si reggono su un sistema che apparentemente sembra precario, ma dura da sempre.
Il quorum sensing è un processo biologico con cui i microrganismi comunicano per percepire quanti dei “loro” sono presenti. Finché sono pochi restano nascosti; appena sentono di aver raggiunto un numero sufficiente “il quorum” cambiano comportamento simultaneamente e attaccano. Sono spore che, nel momento delle avversità, aspettano solo che il vento cambi per sentire il richiamo e tornare a essere un unico corpo.
Questo meccanismo non si rompe: per quanto riguardi un’infinitesimale percentuale di bipedi pensanti, per quanto qualcuno cerchi di sanificare le pareti del sistema, si tratta di spore che tornano sempre.
Anche quando non la vedi, la muffa lavora sotto. Ha bisogno di oscurità e umidità per proliferare: segreti e omertà. Non un’assenza, ma una quiescenza.
Per cui, figlia mia, fai davvero attenzione a questi orchi, abbi paura di loro e non di chi ha un aspetto ripugnante, poiché il loro aspetto a volte è migliore anche del mio.
Resisti agli incanti del lusso, resisti alle favole, abbine timore.
E tu, ragazzo che ti avvii a una carriera di successo, continua a correre a testa bassa in mezzo alle persone comuni. Prendi le distanze dagli orchi anche se inevitabilmente dovrai incontrarli.
Non farti abbindolare.
Non esiste una vetta in cui arrivare: esiste una buona strada fatta d’incontri, di scambi, di conoscenza; non cercare di entrare nei club degli invincibili, nessuno lo è in fondo.
Se da una cima ti fermi a vedere quello che c’è sotto, capisci soltanto di essere solo.
I cannibali, o orchi, sono come predatori apicali: consumano la vita di chi sta sotto per riaffermare che la loro esistenza ha più valore della biologia altrui.
Gestiscono le fila di ciò che resta in superficie, quello che è alla portata di tutti, influenzando il pensiero delle prede, degli altri organismi.
Hanno ammiratori e gregari: persone disposte a mangiare i propri figli per avere un minimo della loro considerazione, considerazione che non è mai reale, ma unicamente di comodo.
Non hanno sentimenti, insegnano a non averne; l’empatia è loro nemica e cercano d’insegnare che sia anche nostra nemica.
Ci odiano profondamente e ancora di più quando piangiamo per i morti nelle guerre, i morti sul lavoro, i morti a causa della schiavitù, quelli morti a causa dei loro simili.
Rivestono d’oro le terre dove giacciono i loro cadaveri con la promessa di una bellezza che sarà solo per pochi eletti: una bellezza che è come una dama putrida vestita di tutto punto, capace di ingannare alla vista ma non all’olfatto.
Si prendono terra, cielo e mare, quello stesso mare in cui giacciono decine di migliaia di corpi che avrebbero voluto toccare terra, lavorare, avere un futuro.
Quella stessa terra da sfruttare fin dalle viscere, usando altri corpi.
Che importa se poi quei corpi vengano sommersi dalla terra, da quella stessa terra che i cannibali hanno rubato.
Siamo bianchi per puro caso, somigliamo a loro, ma vi prego figli miei, non siate mai come loro.
Non lasciatevi ingannare quando vi dicono che il nostro nemico è quello sepolto sotto le macerie di una miniera di coltan o il ragazzo che giace sul fondo del Mediterraneo.
A loro, di questa carne che hanno ucciso, non importa niente.
Non è odio, non è neanche indifferenza.
E noi possiamo distinguerci solo in un modo: continuando a sentire il peso dei corpi, continuando a piangere i morti che conosciamo e anche quelli che non conosciamo.
Gli orchi vincono quando smettiamo di provare empatia.
Non solo quando comandano.

“Trionfo della morte” olio su tavoladi Pieter Bruegel il Vecchio
1562 – Museo del Prado, Madrid.